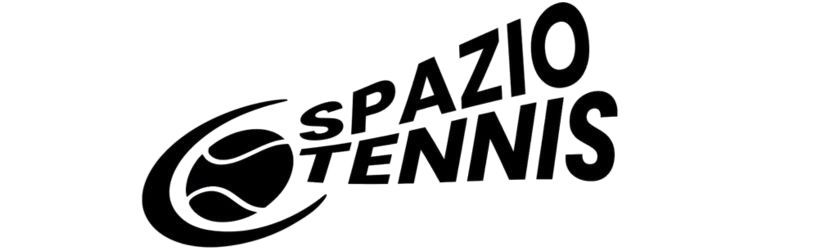di Sergio Pastena
Imitando il nuovo Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Crozza diceva: “Sono talmente poco visibile che nella foto della mia patente io sono quello dietro”.
Ecco, dovessimo identificare il Mattarella del tennis moderno dubbi ce ne sarebbero ben pochi: risponderebbe sicuramente al nome di Kevin Anderson, ventinovenne da Johannesburg. Identificare un motivo non è cosa facile, perché il buon Kevin possiede tutta una serie di “X Factor” che singolarmente sono sopportabili ma, presi assieme, determinano una condanna all’oblio.
Citandoli in ordine sparso: pochi risultati di rilievo in carriera se paragonati alla classifica, con una marcatissima vocazione da choker. Un gioco che non spicca per originalità e/o spettacolarità. Carisma pressocchè nullo corroborato da un carattere schivo. Nazione di nascita, il Sudafrica, da qualche anno tennisticamente morta. A tutto ciò si aggiunga la sciagura estetica di avere un viso che è la disperazione dei fotografi: ogni volta che Anderson sorride da qualche parte un docente di Estetica muore. E se qualcuno pensa che l’ultimo punto non sia rilevante, si chieda a chi affiderebbe la pubblicità della sua nuova linea di profumi, se a lui o a Feliciano Lopez.
Tutte le caratteristiche di cui sopra non sono certo un’esclusiva: per ogni singola categoria troverete molteplici esempi. Dal perdente (Verdasco) al non carismatico (Ferrer), da quello nato nel posto sbagliato (Gulbis) a quello col gioco noioso (Isner) passando per i tennisti brutti come un remake dei Vanzina (uno su tutti, Karlovic). Ma Anderson ce le ha tutte, e il tutto porta anche ad amplificare paradossalmente i suoi difetti.
Prendiamo il gioco: Anderson non è nè Isner nè Karlovic. Pur essendo alto quasi quanto loro e avendo un servizio a dir poco esplosivo, le sue percentuali sono profondamente diverse, con un 17% di break che lo pone sui livelli di un Gulbis e un 86% di servizi tenuti dignitosissimo ma ben lontano dal 90% e oltre dei due compari battitori. Anderson gioca meglio. In giro c’è persino chi lo definisce un tennista “all around”, anche se bisognerebbe andarci piano: il concetto di completezza è sempre relativo ai livelli che si raggiungono. Un tennista da Futures è completo se fa discretamente cinque o sei cose, lo stesso tennista piazzato nei tornei Atp è uno scarpone (pur essendo oggettivamente fortissimo comparato al resto dell’umanità tennistica). Nel caso di Anderson ci sono limiti, ma è altrettanto vero che degradarlo a una versione evoluta ma con meno risultati di John Isner è eccessivo: il sudafricano ha sempre fatto qualcosa di più “oltre i tre colpi” e questa è la chiave della vittoria arrivata stanotte, la più importante della sua carriera.
Anderson ha battuto Andy Murray agli ottavi degli Us Open, e a destare sensazione non è tanto il cosa ma il come. Vedi un match con tre tie-break e pensi che sarà stata una vittoria alla Anderson: tengo il servizio per tutto il match, breakko una volta, gioco bene i punti decisivi e me la porto a casa. Ora, a prescindere dal fatto che, contro i big, questo Anderson non era mai riuscito a farlo fino in fondo, la vera cartina da tornasole del match del sudafricano in questo caso sono le statistiche. Azzardiamo un paragone col match perso al quinto da Djokovic a Wimbledon e tutto sarà più chiaro.
Anderson ha piazzato meno aces: 25 su 177 (14.1%) contro 40 su 246 (16,2%). E ha anche vinto meno punti sulla prima: 79% contro 83%. Il numero dei doppi falli è stato stabile, la velocità della battuta inferiore. Sono statistiche chiaramente influenzate dalla superficie differente e dalle qualità in risposta di Murray, ma il punto è proprio quello: tra una vittoria in 4 set e una sconfitta in 5 qualche differenza ci passa e la differenza Anderson l’ha fatta nei punti “giocati”. Quattro break contro uno e 37% dei punti di risposta vinti, mentre contro Djokovic erano stati il 28%. 81 vincenti totali rispetto ai 71 messi a segno contro il serbo, pur con un numero di gratuiti superiore. E manco a dirlo, conversioni migliori: palle break salvate 73% contro 37%, convertite 44% contro 13%.
Questi pochi numeri possono restituire a chi non ha visto la partita quanto in campo ieri è sembrato evidente. Ieri Anderson teneva lo scambio e non si limitava a fare quello: attaccava, metteva pressione, trasformava situazioni difensive in offensive, il tutto contro uno dei migliori giocatori dell’era moderna che, a dirla tutta, non stava giocando affatto male (venti gratuiti totali, niente di che). Persino nel terzo set, quando Murray ha recuperato un break e beneficiato di un paio di occhi di falco millimetrici, la sensazione era che il trend della partita non fosse cambiato chissà quanto.
Il tie-break del quarto è stato spettacolare, con Anderson che non ha sbagliato un punto e per una volta, in occasione di un doppio nastro sanguinoso (dentro il suo, fuori di poco quello di Murray) è stato aiutato da una fortuna che fino a quel momento l’aveva ritenuto troppo anonimo per degnarsi di aiutarlo. E così quello che fino a un paio di Slam fa sarebbe stato solo un folcloristico confronto tra i due incisivi più belli del circuito si è trasformato in una prima volta che sa di favola. Una favola vissuta in silenzio, raccontata poco ma non per questo meno magica.
Mai stato un grande fan di giocatori come lui, ma ieri il sudafricano un applauso me l’ha strappato: dopo sette sconfitte agli ottavi, mai quarto Slam fu più meritato. Alla salute.