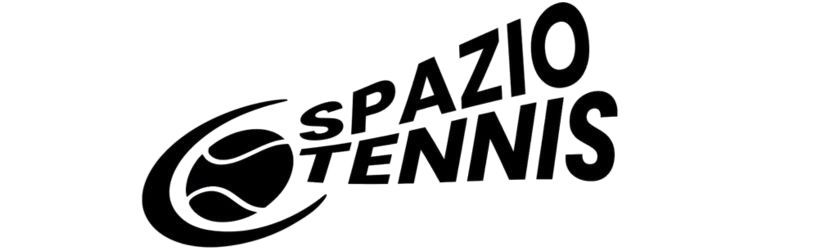21 Maggio 2013, Champaign, Illinois. Quando una competizione che dura mesi e mesi si sviluppa lungo un numero considerevole di avvenimenti e vede impegnati, da protagonisti, diversi giocatori, e si decide in pochi, decisivi, attimi, ben si comprende quanto lo sport possa essere al tempo stesso bellissimo, perché emozionante, ma anche crudele. Più che crudele, sportivamente parlando. Fulgido esempio è quello che accadde nelle fasi salienti della finale NCAA 2013 tra i Cavaliers della Virginia University saggiamente guidati da Brian Boland, da noi intervistato lo scorso mese di giugno, e i Bruins della UCLA. Come è noto, negli sport universitari, il titolo di squadra riveste maggiore interesse perché evidenzia più marcatamente quanto un ateneo stia lavorando bene, e se a questo fatto aggiungiamo la grande annata che le due compagini avevano vissuto, capiamo quanto, in quel pomeriggio, ci fosse in campo. Dopo che il punto del doppio fu appannaggio dei rappresentanti della Mr. Jefferson’s University, i primi cinque singolari equilibravano nuovamente la situazione: 3-3. Il vincitore sarebbe dunque stato stabilito dall’ultimo singolare in programma, quello tra i “numeri 3”, da una parte, quella californiana, il francese Adrien Puget, dall’altra Mitchell Frank. E il closer non poteva essere da meno rispetto al resto della sfida, con un inizio a senso unico (6-0 Puget) presto dissoltosi per lasciar spazio ad una contesa punto su punto, che sul 5-4 del terzo set sembrava nuovamente arridere al transalpino, che riusciva a salire a match-point, ma, come tradizione vuole, una volta sciupata l’occasione in maniera piuttosto grossolana, il destino finiva tra le mani di Frank, che non tremava e con un 7-5 regalava alla Virginia il primo titolo NCAA a squadre (bissato poi nel maggio scorso). La gioia di Boland “È un successo che meritano i ragazzi, tutti quanti, non solo quelli presenti ora, qui, in Illinois, ma anche quelli che negli anni passati se lo sarebbero meritato” vedeva il giusto contraltare nella delusione degli sconfitti. “Ci rifaremo, ce lo saremmo meritato anche noi”.
19 novembre 2015, Champaign, Illinois. “So che questo posto ci deve ancora qualcosa, la ferita del 2013 non è del tutto cancellata”. A pronunciare questo pensiero il giovane statunitense MacKenzie McDonald, ragazzo di ottime speranze – probabilmente, dopo Noah Rubin, il tennista che ha scelto il percorso universitario su cui gli yankees nutrono maggiori speranze in ottica professionistica – che dall’autunno di due anni fa ha scelto di unirsi ai Bruins per proseguire la propria educazione scolastica. Nato a Berkeley nel 1995, MacKenzie è salito agli onori della cronaca nell’estate del 2013 quando, da diciottenne sconosciuto, è riuscito a qualificarsi per il tabellone principale dell’ATP1000 di Cincinnati, sconfiggendo Nicolas Mahut e Steve Johnson – quest’ultimo una sorta di icona per qualsiasi tennista che nell’ultimo lustro ha deciso di giocare a tennis da universitario, soprattutto per coloro i quali lo fanno in una delle università della PAC-12, la divisione dove rientra anche la University della South California, che Stevie ha frequentato. MacKenzie in questo autunno ha inoltre guadagnato i punti per entrare nella Top-500 della graduatoria mondiale e quelle parole, da lui espresse, fanno ben comprendere quanto quella sconfitta possa ancora bruciare, poiché lui, all’epoca, non faceva nemmeno parte del roster, per UCLA si era limitato a firmare una lettera di intenti che confermava la sua futura adesione. Niente di più. Eppure sapeva che per i Bruins quei campi avrebbero dovuto riservare qualcosa di positivo. “Durante il match di quarti di finale, nel campo di fianco al mio giocava Clay Thompson, e da lontano, nelle pause di gioco, non potevo fare a meno di buttare un occhio al tabellone per capire quanto stesse, perché so che Clay durante il match point fa sempre qualcosa di strano, per cui dovevo essere sicuro che non sarei stato nel bel mezzo di qualcosa di importante quanto questo sarebbe accaduto.”
You will rarely see something like this after a match won: @ClarenceAThomp is a real boss (thx to @LucaBeck for gif) pic.twitter.com/2TrJPT5FOM
— Stefano Berlincioni (@Carretero77) 20 Novembre 2015
Questo non sarebbe successo, poiché l’incontro di McDonald, contro Mitchell Krueger, si sarebbe concluso in una maniera più lineare rispetto a quella del campo affianco, che avrebbe comunque visto Clay Thompson rimontare un set di svantaggio a Austin Krajicek, altro prodotto statunitense, ma di ben altra generazione, che si è preso il lusso di iscrivere il proprio nome tra quelli che nella vita sono stati catalogati, almeno per una settimana, tra i migliori 100 giocatori al mondo. “Battere Rola e Krajicek nel giro di 24 ore, due ragazzi che per me possono tranquillamente essere definiti top-100, mi ha finalmente dato quella scossa positiva che andavo cercando.” Ah, Clay era in campo, quel 21 maggio 2013, perdendo sia l’incontro di singolo che di doppio. Insomma, che lui avesse in cuore una rivincita sui campi di Champaign era più scontato, anche se il concetto di rivincita, per Thompson, sarebbe da estendere all’intera carriera.
Alto quasi 2 metri, dotato di un servizio molto potente, con cui, quando in giornata, riesce a raccogliere molti punti, e di un rovescio che è sicuramente il colpo con cui da fondo è più solido, Clarence – detto Clay – Thompson sfrutta inoltre l’altezza per spingersi avanti, ma non è soltanto questo. I suoi incontri sono un’emozione continua perché il ragazzo, sul campo, pare spiritato. È un muoversi continuo, non si ferma mai tra un punto e l’altro, non è capace di trovare pace, ma senza però dare segnali di nervosismo “La cosa che mi piacerebbe, in futuro, è che ci fossero sempre un centinaio di persone a vedere le mie partite per lo spettacolo che io posso garantire, è un obiettivo che mi tocca più da vicino del diventare un top-100”. La strada, nonostante la semifinale colta a Champaign, è comunque parecchio lunga.
Tra il 2010 e il 2014, come prima evidenziato, Clay Thompson ha prestato servizio tennistico e scolastico presso la UCLA, frequentando il circuito NCAA dove, per un breve periodo, ha anche rivestito il ruolo di primo giocatore della graduatoria di singolare. Grazie a questo risultato, nella sua prima estate da professionista, ha anche ricevuto una wild card per il primo avvenimento ATP della sua carriera, quello di Newport; il destino beffardo lo ha però opposto a Steve Johnson, ex recordman a livello universitario, nonché ex-avversario proprio di Clay in svariate sfide a livello collegiale, tutte vinte da Stevie l’imbattibile. “Curioso che questo incontro, che era diventato una sorta di classica nelle sfide della PAC-12, si sia svolto agli antipodi, nel Rhode Island”. L’incontro fu completamente a senso unico, con Thompson che ha impiegato sei giochi prima di vincerne uno e ne ha raccolti tre in totale, bottino più esiguo di quanto le sfide precedenti non avessero evidenziato. Nulla di strano, l’emozione dell’esordio si sarà fatta sentire. Semmai i problemi sarebbero emersi successivamente, quando Clay avrebbe fallito in sette occasioni su sette la qualificazione nei Challenger, tra estate e autunno, e perfino nei Futures più di un quarto di finale non sarebbe stato in grado di collezionare.
Quest’anno a dire il vero, qualche bel risultato è arrivato, Thompson ha innanzitutto ascritto il suo nome all’albo dei vincitori di un torneo ITF – colto in Messico – ha raggiunto un’altra finale, e ha messo insieme tanti piccoli tasselli che hanno mostrato una crescita, costante, lineare, ma certamente non fulminea. Questo fatto ha inciso inizialmente da un punto di vista economico, dal momento che il ritorno, con questi risultati, non era a tal punto sufficiente che, per finanziarsi l’attività, è dovuto ricorrere al proprio denaro: nessuno sponsor. Eh, sì, qualche partita in più veniva vinta, ma quando, quest’autunno, il circuito Challenger è tornato a frequentare quei circoli in cui Clay, da collegiale, si era mosso con grande disinvoltura e le sconfitte al secondo turno di qualificazione diventavano l’inevitabile conclusione di ogni manifestazione, Scott Bailey, il suo allenatore, ha pensato che fosse necessaria una bella scossa per il suo assistito, così abbandonando Charlottesville e raggiungendo Knoxville per una nuova avventura in qualificazione, hanno deciso che questa sarebbe giunta col cambio di racchetta. Però in una maniera originale “cercammo tre racchette che potessero andare bene all’interno di un gruppo di racchette donate… Sì, proprio così. Le ho testate nel primo torneo, a Knoxville, e nonostante l’ennesima sconfitta al secondo turno contro Henri Laaksonen, la mia prestazione è stata sicuramente migliore, positiva. Abbiamo così deciso di proseguire.” A Champaign, dove dodici mesi prima Clay aveva subito una sconfitta abbastanza rocambolesca contro Marek Michalicka che aveva riaperto l’antica ferita, al secondo turno il sorteggio gli opponeva Stefan Kozlov, il pensiero che la serie potesse interrompersi nuovamente a quel livello si è insinuato, ma forte della bella vittoria ottenuta a marzo, Clay è stato capace di invertire il pronostico: era la quarta sfida tra i due nel 2015. Da quel momento in poi, Thompson ha giocato il miglior torneo della sua ancora giovane carriera.
Il 23enne californiano ha prima recuperato un set e un break di svantaggio a Dennis Nevolo, che è anche andato a servire per il match sul 6-5 della terza frazione, ha poi regolato in due set l’ex granatiere della Ohio University Blaz Rola e ha poi sconfitto, ancora una volta in rimonta, come già detto, Austin Krajicek. In semifinale ancora Henri Laaksonen, l’elvetico che in questo squarcio di stagione pare aver trovato il lume della ragione: non è bastato a Clay un set di vantaggio, la partita si è decisa al tie break finale, dove il servizio non lo ha aiutato a dovere: Thompson non si è demoralizzato, con un ace – unica prima del tie break – e un bel dritto ha dimezzato il gap creatosi all’inizio (da 0-4 a 2-4), ma è poi capitolato comunque 2-7. Senza alcun gesto di delusione, c’è da dire, per quanto in campo non sia stato fermo mai un attimo, avendo una carica e un’adrenalina in corpo contagiosa. “Penso che il primo punto sia stato fondamentale per l’esito dell’intera contesa, ho provato a spingere col dritto, ma alla fine ha vinto lui lo scambio”. Sconfitto sì, ma una semifinale in un Challenger è il modo migliore per guardare con fiducia al futuro e smacchiarsi di dosso la cocente sconfitta di due anni prima.
Due Bruins in semifinale non era assolutamente un’eventualità così semplice da prevedere, e pazienza se nessuno dei due è riuscito a superare il penultimo ostacolo: MacKenzie McDonald, impegnato nella seconda semifinale, ha avuto a disposizione ben 15 palle break per provare a strappare il servizio a quel predestinato che risponde al nome di Taylor Fritz, ma non c’è stato alcun verso di chiudere la contesa con un risultato diverso dal 6-7 6-2 6-2 che ha premiato l’avversario. La serie di palle break annullate consecutivamente da Taylor si è interrotta, in finale, a 28: era cominciata nel secondo turno con le 3 annullate a Daniel Evans, ci sono state le 5 contro Jaziri e le 15 con McDonald ed è capitolato solo alla sesta in finale contro Henri Laaksonen. Per lui, che già nei precedenti tornei aveva mostrato questa attitudine, non pare così complicato – “Soprattutto quando sono in una situazione di parità, mi dico ‘Ehi, questo punto non posso perderlo, perdere il punto non è una possibilità” – anche se in finale il ragionamento non è funzionato, perché dopo aver perso l’imbattibilità, ne ha subiti altri quattro, di break, che hanno regalato il titolo a Henri Laaksonen, il primo in carriera a livello Challenger. Più di questo, a Fritz sarà dispiaciuto che a sfumare è stata la wild card per l’Australian Open, con questa sconfitta finita tra le mani di Noah Rubin. È soltanto una questione di tempo.