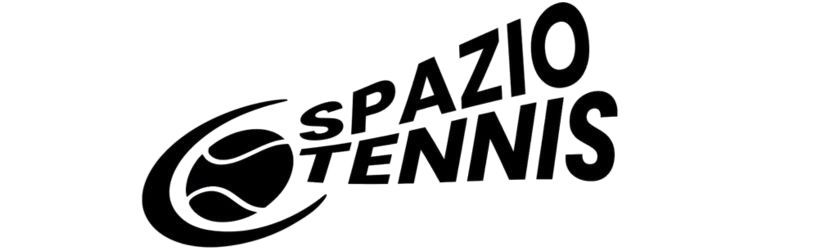di Mario Polidori
Alessandro Baldoni è un uomo gentile, disponibile e pacato.
Ha la consapevolezza dei grandi ed il piglio fiero di un antico romano, ti guarda sempre dritto negli occhi, cercando nei tuoi la stessa trasparenza ed onestà intellettuale, e se non la trova non resta deluso, semplicemente sa con chi ha a che fare.
Capisco subito, fin da quando gli ho chiesto se fosse stato possibile per me scrivere di lui, che ha molto da raccontare e capisco anche che ha deciso di farlo molto volentieri.
Ci siamo incontrati alla Vavassori, a Palazzolo sull’Oglio, negli uffici della sede, perché, da qualche tempo, ha iniziato a collaborare con l’Accademia.
Conoscevo Baldoni, quando giocava, lo conoscevo come si può conoscere un campione, seguendo le sue imprese su giornali e raccogliendo notizie da chi ne avesse, vere o false che fossero.
Alessandro è classe 1968, ed io seguivo ormai il tennis da appassionato e non più da agonista, mi era vicino, anche per i suoi atteggiamenti un po’ ribelli e spavaldi, tipici del sangue romano, che scorre anche nelle mie vene e con la stessa velocità.
E quante cose non si vedono e non si sanno della carriera di un atleta, quante idee ci facciamo su come stanno facendo questo o quello, su come lo stanno vivendo.
Ma come diceva qualcuno, un tennista è un uomo di spettacolo che si esibisce praticando uno sport, e quello che succede dietro le quinte non lo vede mai nessuno.
Ognuno racconta quello che vuole, per professione o per mestiere, per opportunità o anche solo per vanità, ognuno si prende un pezzo della grandezza di un uomo e lo cucina e condisce secondo i gusti di chi lo ascolta.
Quanto è difficile per me adesso raccontare Alessandro, che mi ha concesso tutte le sue verità, che mi sovrastano, pur solleticando il mio senso di compiacimento per essere riuscito ad entrare, che mi costringono ad innalzare il mio livello al suo.
Se non mi dovesse riuscire, però, so con certezza che non avrò bisogno di essere perdonato, mi ha consegnato tutto, dandomi l’impressione che sapesse che avrei fatto del mio meglio.
“Ho iniziato a giocare a 10 anni, in un circolo di periferia vicino casa, abitavamo praticamente sopra i campi.
Mio padre giocava e gli piaceva molto, era uno sportivo, ex campione di judo e di lotta, ed anche a me piaceva l’idea di praticare uno sport, che in quel momento, rappresentava un modo divertente per passare il tempo, piuttosto che stare in giro a far niente.
Iniziai insieme a mio fratello, più grande di me di quattro anni.
Lui era il fratello più bravo, più bello, più intelligente, era il primogenito e per mio padre era sempre al primo posto.
Ma non me ne importava granché, io facevo lo stesso quello che mi piaceva e lo facevo per come mi andava di farlo, era più un problema di mio fratello che mio, anche perché mio padre non scherzava affatto.
Il tennis si rivelò per me talmente divertente, che diventò immediatamente una malattia, ma non una malattia come si dice spesso, indicando un modo appassionato di vivere un’esperienza, ma una malattia vera, una patologia, e sono convinto che diventare grandi in uno sport è sempre frutto di una patologia, perché la volontà, la disperazione, la forza, il coraggio che ci vuole per trovare il successo è la stessa che occorre ad un malato per trovare la cura.
Di quello che avevo intorno non me ne poteva fregare di meno.
Della scuola, del circolo, frequentato da gente molto formale, tutti disciplinati, allineati e coperti come i marines.
Io giocavo e basta, non avevo neanche il maestro, inteso come oggi lo intendono, ho fatto un corso SAT di quelli con cinquanta bambini in campo, con vari collaboratori della scuola che si avvicendavano, insomma avevo sempre qualcuno che mi lanciava le palle, ma niente di più.
La mia scuola era seguire da fuori le lezioni degli altri e poi andare sempre in giro con la racchetta, quella del supermercato, con le corde di quel nylon bianco con la righina blu, a fare i “muri”, il più possibile.
Dopo sei o sette mesi, mio padre prese in gestione un piccolo club a Colonna, zona Castelli Romani, per lasciarci giocare, a me ed a mio fratello, per tutto il tempo che volevamo, così ci teneva lontani dalla strada.
Ed era lui a seguirci.
Il maestro arrivò per mio fratello, ed io continuavo ad imparare da solo.
Era il classico maestro di tennis, letterario, bello, molto figo, di quelli da club vacanze, non ricordo neanche come si chiamasse.
Lui faceva lezione a mio fratello ed io imparavo guardando.
E mentre la mia “malattia” diventava via via incurabile, anche mio padre iniziò ad accusarne i sintomi e decise di raccogliere notizie su dove e come poteva darci migliori opportunità.
A 11 anni approdammo all’Augustea, dove incontrai Gianni Bertuccelli, quello che poi diventò il mio secondo maestro, dopo mio padre.
Con lui ebbi la possibilità di consolidare quello che avevo imparato fino a quel momento da solo, all’epoca non si parlava di agonismo, bisognava imparare bene e basta.
Feci qualche mese di scuola con lui, in un gruppo, poi papà ci portò al TC Garden, dove c’era il maestro Ezio Di Matteo, “Pancho”, un mito, un ex Davis.
Avevo davanti ai miei occhi il vero mondo del tennis, ero un bambino che aveva la possibilità di convivere con i grandi.
Zugarelli, Barazzutti, erano tutti lì ad allenarsi, quale posto migliore per guardare ed imparare?
Pancho s’innamorò di me, della mia passione, vivevo in simbiosi con lui, ho incamerato tante di quelle nozioni sul tennis, e soprattutto valori, perché erano uomini di valore, prima ancora di essere tennisti.
Mi stava vicino, non era coaching il suo, ha solo accelerato il corso della malattia.
Andavo sempre in giro con una busta di palle, e tiravo dentro chiunque fosse disposto a giocare.
Ho passato giornate intere a giocare così.
Ancora oggi, quando incontro qualcuno dell’epoca mi fa: “…Iaio,…voi fa’ du’ palle?”.
A 12 anni, cominciai a sognare di diventare un campione, vicino ai campioni, uno di loro.
Un ambiente sano, che faceva volare la mia motivazione, i giocatori erano giocatori, non coach, bastava guardarli per sentirsi raccontare la storia, per sapere cosa fare.
Un sogno vero.
Iniziarono i tornei, l’occasione per farmi vedere.
Non vincevo mai, ma tutti dicevano che ero buono.
Fino ai 13 anni giocavo tra il Garden ed altre due strutture collegate.
Prima dei 14 siamo andati a vivere a Senigallia, mio padre aveva preso in gestione un bar.
Ogni giorno, la mattina a scuola in bicicletta, con la borsa del tennis, come avessi un violino, a farmi prendere per il culo da tutti: “…chi ti credi di essere…”, mi dicevano, ed il pomeriggio in treno fino a Pesaro per giocare, ed a casa la sera, un’ora e mezza ad andare ed un’ora e mezza a tornare.
A Pesaro c’era Mike Barr, con due erre mi pare, americano, ottimo tecnico.
Stavo benissimo, anche perché ero da solo, senza papà, che cominciava a far sentire il suo peso e le sue pressioni in quello che facevo.
Era durissimo con me, l’unico modo che conosceva per farsi rispettare era mettere paura, me le dava anche, e non potevo liberarmi da quel giogo, perché era lui quello che si occupava, quando poteva, della mia preparazione atletica da sempre, e finivo sempre nelle sue mani……. in tutti i sensi.
Io da parte mia, non avevo un buon carattere, ero una testa calda, ma lui non si poteva reggere.
Più avanti, la sua preparazione era sveglia alle 6 e mezza ogni mattina, 10 km di corsa intorno al lago o 5 km in salita 25% con scatti e ripetute, 1.000 addominali e via dicendo.
Un massacro, di cui gli sono senz’altro grato, perché altrimenti non sarei andato da nessuna parte, ma mai un bravo, mai una pacca sulla spalla, per quanto io fossi diligente, sempre a darmi addosso, avevo la netta sensazione che volesse solo affermare e curare la sua personalità, piuttosto che aiutare me.
Sensazioni che un bambino prova, a torto o a ragione.
Pensavo di capire i disagi, le privazioni, le sofferenze che aveva vissuto da ragazzo, senza padre , con una madre durissima, ma non lo capivo, pensavo soltanto: “…ma io che centro papà?…”
Come per qualsiasi figlio lui per me rappresentava tutto, la forza, il coraggio, la lealtà, era il mio idolo.
Ma io non ce la facevo, per me era troppo, dovrà perdonarmi anche questo.
Una volta mi capitò di battere in allenamento un certo Izaga, il numero 40 del mondo, per 6-3 6-3 e quando uscii dal campo mi disse che ero uno stronzo, perché quello era il mio livello!, e non ero io il numero 40!
E non che io fossi svogliato, anzi.
Un’altra volta, andando a giocare, gli chiesi di non farmi giocare con uno che odiavo.
Dopo un po’ si presentò dicendomi che avrei giocato con lui.
Giocai e vinsi facile, ma era tale l’odio, che lo feci cercando di farlo sentire una schifezza, irridendolo.
Sulla strada del ritorno, papà me le diede per tutto il tempo, perché mi ero comportato male con il mio avversario, non avevo avuto rispetto.
Il giorno dopo andai a giocare tutto livido in faccia.
A Pesaro giocava, la serie A, Ferrante Rocchi, altra fortuna che ho avuto.
Posso dire che il tennis per me, la scuola, è stato imprinting, costruito vicino ad uomini eccezionali, più di qualsiasi altra cosa.
A 14 anni arrivarono le prime vittorie, diventai campione regionale nelle Marche, e poi nello stesso anno, papà aveva venduto il bar ed eravamo tornati a Roma, e diventai campione anche del Lazio.
Da quel momento è cominciato l’incubo, l’incontro con persone che hanno cercato di appropriarsi del mio sogno, il continuo tentativo di sostituirsi a me, ero diventato il loro riscatto.
Era il più profondo livello d’ignoranza, perché il successo dipende da te, lo raggiungi con l’aiuto degli altri, non con la prevaricazione.
Il livello della fatica è enorme, e le malattie non si educano, piuttosto si aiuta a curarle.
Tra i 14 ed i 16 anni ho girato per maestri e situazioni, rimanendo ancora legato a Pancho, Ezio di Matteo, finchè non ho incontrato Antonio Rasicci, allora direttore della Scuola Nazionale Maestri.
Feci un provino e da quel momento ho frequentato solo centri federali, giocando con gente come Pistolesi, Filippi, Fratta, Simmons, Tesorone, dove ho scoperto l’agonismo vero, la fatica, il lavoro, la dedizione, i risultati.
Rasicci diventò il mio maestro e punto di riferimento, e ancora oggi lo è.
E papà, intanto, aumentava la pressione.
Fino ai 20 anni, tornei, vittorie e soddisfazioni, come battere Canè, allora numero venti del mondo nella semifinale degli assoluti dell’88.
Nel giro della nazionale con Camporese e tanti Top 100 nel carniere, semifinale a Marrakesch, dalle qualificazioni, il torneo del Foro Italico in tabellone, perdendo in tre set con Ronald Agenor, che poi fece semi, e tante wild card, degnamente onorate, in tornei importanti, i Grand Prix dell’epoca.
Raggiunsi la posizione 190 nel ranking, anche se per una settimana, ed allora perché fosse ratificata occorreva che ci stessi per tre settimane, comunque ero tra i migliori 200.
Ho incontrato e battuto anche Stich.
Io potevo davvero farcela, ne avevo la consapevolezza, ero certo.
Ma mio padre, sembrava fosse lì, ad aspettarmi.
Reggere la sua pressione diventava sempre più difficile, perché diventava sempre più difficile il tennis che occorreva giocare per vincere.
Da ragazzino riuscivo a fregarmene di lui, ma più andavo avanti e più diventava un macigno, una montagna invalicabile.
Vincevo, guadagnavo soldi, ma per lui ero sempre un niente.
E alla fine arrivò l’occasione giusta per smettere.
Avevo 20 anni, andai a giocare alle Pleiadi, a Torino, per la serie A.
Lì c’era Riccardo Piatti che seguiva Caratti, Furlan e Mordegan, insieme a Pino Carnovale.
Io ero di Rasicci e della Fit e per questo non gli piacevo granché, ero più grande dei suoi ragazzi, ed il mio modo di fare da ribelle, lo disturbava, soprattutto perché condividevo casa con loro, e la mia, per lui, era un’influenza negativa.
Mi allenai benissimo da settembre a dicembre, era un momento d’oro, stavo benissimo e tutto andava per il meglio.
A dicembre mi presi una settimana di vacanza, per trascorrerla con la mia ragazza, americana, che aveva voluto farmi una sorpresa.
Ero un professionista, potevo anche decidere cosa fare in vacanza.
Quando tornai, riprendendo il duro allenamento, ero affaticato, ma tutto normale.
Il giorno dopo Riccardo venne da me e mi disse: “Ha telefonato tuo padre.”
Pensai al peggio, non so, un incidente, un lutto, qualsiasi cosa, ma mai avrei potuto pensare a quello che stava accadendo.
Lo chiamai, e dovetti ascoltare, dall’altra parte del filo, un uomo in travaso di bile per quello che era successo, che mi prometteva di venire a punirmi.
Piatti conosceva i problemi che avevo con mio padre, non so come fece a pensare, così facendo, di darmi soltanto una semplice lezione.
Telefonai a Rasicci terrorizzato, chiedendogli di parlare con papà per sistemare la faccenda.
Il giorno dopo mi svegliai, e per la prima volta, mi ero reso conto di non amare più quello che facevo, così, di colpo, irrimediabilmente.
E tutto si fece difficile, la fatica era insopportabile, il risultato assolutamente mediocre, ero svuotato e mi sentivo ormai costretto a fare una cosa che non mi piaceva più.
Partii per la Spagna, per riflettere, poi me ne andai in America.
Era finita.”
Dopo la parentesi americana è iniziata per lui la carriera di maestro.
La sua capacità di incanalare positivamente tutte le esperienze, ne ha fatto un uomo di un equilibrio straordinario, senza che nessuna ruggine di ciò che ha dovuto sopportare l’abbia potuto intaccare.
Evidentemente si tratta d’acciaio.
Di solito le mie interviste durano mezz’ora, ma la storia di Alessandro ha richiesto di più, la sua meritava di più.
Grazie Alessandro Baldoni, quando ti seguivo mi piaceva quello che facevi, che era quello che avrebbero dovuto lasciarti fare.
Intorno a chi vince, o può farlo, troppo spesso si riunisce il peggio, anche quando credono di far bene.
Per amare, però, ci vuole il cuore, che è anche quello che ti fa accettare il peso delle tue scelte, o dovresti non averne.
E lui, il cuore ce l’aveva.
E ce l’ha.
Mi dice, mentre ci salutiamo, che forse non è stato abbastanza forte, per superare tutte le prove.
E questo era per papà, perché c’è stato anche il momento per capire papà, e per capire che gli ha dimostrato tutto l’amore di cui un padre è capace, secondo i suoi codici, con la sua durezza, perché soltanto così nessuno avrebbe mai potuto fare del male al figlio campione.
Search
Cerca
Ultime News
SOCIAL
© Vibes Media SRL
Nessun commento