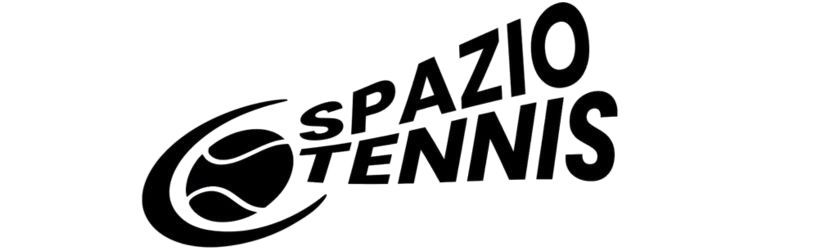di Sergio Pastena
Il Minnesota è lo stato più freddo d’America. E’ la cosiddetta “Stella del Nord”, quella che finisce sulle copertine solo quando ci sono le primarie presidenziali: niente petrolio come in Texas, niente confusione in stile New York, niente scintillii di casinò come nella West Coast. Soprattutto, niente mare: non siamo mica in California. Il Minnesota è grande quasi quanto l’Italia e conta un decimo degli abitanti: chi ci resiste è bravo, in un territorio dove per far spuntare qualcosa dai campi devi passare tutto l’anno a combattere con le gelate e i tornado. Tutto sotto gli occhi compiacenti delle foreste che ti separano dal Canada, troppo basse per ripararti dal vento ma abbastanza estese da mangiare un pezzo di regione che al massimo produrrà cartoline. Conifere, conifere, ancora conifere e ogni tanto pezzi di Mississipi e qualche lago, quando non c’è ghiaccio.
Vi siete fatti un’idea? E’ essenziale per capire quello di cui parliamo, per capire quello che provò la mamma di Howard Schoenfield (ndr: a sinistra nella foto di apertura) quando si trovò a passare da Rochester, cittadina del Minnesota che non arriva ai centomila abitanti, ai quattro milioni di anime di Los Angeles. A Rochester lei stava bene: suo marito Leslie lavorava nella prestigiosa clinica Mayo e avevano tre figli di cui uno, Howard, prossimo ad iscriversi al liceo e che sembrava cavarsela abbastanza bene con la racchetta in mano.
A papà Leslie, quando Howard aveva 13 anni, venne un’idea: facciamolo vedere da qualcuno che ne capisce, hai visto mai… Quel “qualcuno” era Jack Kramer, che si rese conto subito di avere per le mani un prodigio della natura. E allora via, via tutti. Via Howard dal Minnesota, via il padre dalla clinica Mayo, via la madre dalla sua vita: c’è da crescere un campione, tutti a Beverly Hills. Una scommessa a colpo sicuro, insomma: nel corso degli anni, quando cominciava già ad emergere la stella di McEnroe, erano in tanti a pensare che questo ragazzone ancora più riccioluto di Big Mac ne avrebbe seguito le orme.
Howard vinceva tutto: cominciò col doppio, ai campionati nazionali su terra Under 16, nel 1972. L’anno dopo si prese il trofeo di singolare. Nel 1974 vinse gli “USTA National Spring Champions”, preludio ai campionati nazionali under 18, vinti nel 1975. Quindi gli Us Open, nello stesso anno: Schoenfield si sbarazzò in finale, con una facilità disarmante, del neozelandese Chris Lewis, uno che poco prima aveva vinto il torneo juniores di Wimbledon. 6-4 6-2 e Flushing Meadows ai suoi piedi.
Intanto erano passati anni ed anni, nel corso dei quali la madre di Howard non era riuscita ad adattarsi al cambiamento. In passato lei aveva avuto problemi psicologici, che furono moltiplicati dal fatto di trovarsi in un mondo al quale non apparteneva. L’ultima decisione che prese per risolvere il problema di Los Angeles fu anche quella definitiva, quella che non ammette ripensamenti, per nessuno. Sì, perché quando ti uccidi non puoi tornare indietro e lasci un marchio indelebile anche negli altri. La perdita della madre distrusse Howard, i suoi nervi fragili mal celati dietro uno sguardo perennemente triste collassarono e lui finì per la prima volta in una clinica psichiatrica. Ci rimase un anno.
Da questo momento in poi la storia di Howard Schoenfield somiglia alla trama del film “Risvegli”, quello con Robin Williams e Robert De Niro. Per chi non lo conoscesse, la pellicola narra la storia del dottor Malcolm Sayer, che riuscì a “risvegliare” momentaneamente alcuni pazienti affetti da encefalite letargica. Risvegli all’inizio lunghi, poi sempre più brevi ed intermittenti.
Il primo fu nel 1976, quando Howard decise all’ultimo secondo di presentarsi in campo per difendere il titolo americano: non giocava a tennis da mesi, non era allenato eppure arrivò fino alle semifinali, dove venne battuto da Larry Gottfried, fratello del più famoso Brian. A dirla tutta, più che da Gottfried venne battuto dalle vesciche ai piedi: il suo allenatore dell’epoca, Paul Cohen, descrisse la sua partita come la cosa più eroica che aveva visto in vita sua. Intanto, però, era tempo di passare tra i professionisti ma le finanze erano quelle che erano. Una coppia benestante di Ponte Vedra (Florida, l’altro capo dell’America) lo conobbe a un torneo e decise di sponsorizzarlo per due anni. Già all’epoca, a sentire i loro racconti, era evidente come Schoenfield soffrisse di una enorme fragilità di base. Ad allargare la falla fu la morte della madre, a distruggerlo fu l’enorme pressione messa su di lui. Fino al 1978 il bilancio di Howard fu di una sola vittoria a fronte di 18 sconfitte, cosa che lo costrinse a ricominciare dai Challenger. Intanto erano spuntati nuovi “futuri McEnroe” da sfamare.
Neanche il downgrade fu un successo: arrivò qualche risultato, un paio di quarti di finale e persino una finale in quel di Concord, ma appena il livello si alzava un attimo Schoenfield sentiva la pressione e si faceva sbattere fuori, puntualmente, da atleti spesso meno forti di lui. Possibile che fosse diventato un brocco tutto a un tratto? No, il problema era nella testa e lo sapevano tutti ma, mentre lui chiedeva “tranquillità”, non riusciva a sottrarsi al suo destino e continuava a fare il globetrotter per tutta l’America, collezionando sconfitte su sconfitte. Tutto fino all’aprile del 1980. Poi il secondo risveglio.
Schoenfield, all’improvviso, ricorda come si fa: a Tulsa spazza via quattro giocatori, tra i quali Gorman e Lutz (davismen americani) per trovare in finale Trey Waltke, fresco Top 50. Nel primo set l’avversario gli dà filo da torcere e la spunta 7-5, poi Howard mette la quinta e lo demolisce senza pietà: 6-1 6-0, primo titolo in carriera. A Los Angeles, la settimana successiva, butta giù un altro “pezzo da 90”, Erik Van Dillen, e quasi sorprende il leggendario Stan Smith.
Chi a questo punto si aspetta il lieto fine, non ha visto “Risvegli”. La carriera di Schoenfield finisce lì: la luce si spegne di nuovo, tra maggio e gennaio del 1981 perde dieci partite di fila e subito dopo rientra in clinica per non uscirne più. La diagnosi è impietosa: schizofrenia paranoica. Non si parla di lui da oltre vent’anni, neanche quell’animale onnivoro che è il web fornisce informazioni utili. L’ultima traccia è un articolo del 1996, che lo descrive confinato nella clinica “Happy Home”, il classico nome che fa a cazzotti con l’ambiente. Ci avete mai fatto caso? I luoghi tristi come case di cura e cliniche psichiatriche si chiamano tutti “Villa Serena”, “Casa Felice” o robe del genere. Il suo medico curante era abbastanza lapidario riguardo la sua situazione: “Sente le voci, delira, è paranoico”.
Impossibile individuare solo una causa. La morte della madre, certo, ma i suoi fratelli hanno avuto una vita normale pur avendo prospettive più modeste. Lo sradicamento dalle sue origini… ma all’inizio Howard non sembrava averne risentito. Il tennis? Quello forse no, almeno non il tennis in sè: però le pressioni dell’ambiente certamente hanno contribuito. Già all’epoca le ansie, le attese e gli allenamenti stile “Full Metal Jacket” facevano parte del gioco. Logica spartana, solo i migliori sopravvivono: c’è chi ce la fa, c’è chi molla tutto. E c’è chi è troppo debole anche per mollare, come Howard, e finisce per farsi inghiottire e sputare senza reagire, con quel viso triste e quel ventaglio di ricci immenso ma sempre troppo piccolo per proteggere una mente di cristallo.