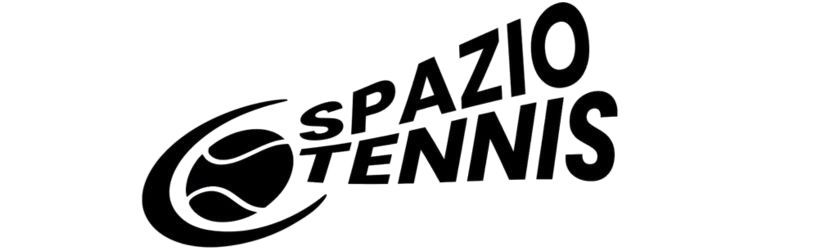di Piero Blanchini (alias Archipedro)
Pensieri da Archi-viarsi: diario d’un padre allenatore (che pensa d’aver ragione ma si ritrova seduto dalla parte del torto…).
Li scruto attentamente, questi bambini, e ricordo le parole d’un amico sacerdote ad uno dei suoi tanti battesimi… “Chissà mai quale sarà il progetto che attende questa creatura…”. Beh, penso io, l’importante è che ci sia, un progetto. E, almeno nel caso del don, la fede nell’ineluttabile disegno esistenziale di stampo divino è rimasta monolitica. Mentre io, che m’immagino il motore dell’eternità come una sorta d’infinita macchina energetica (…), più banalmente mi chiedo come potrà essere spesa tanta voglia di correre. Così giocosa, necessaria ma soprattutto umana… A cosa servono quelle loro pile atomiche se non li aiutiamo a dare un senso organizzato ai loro sogni? Ai loro sogni. Di cui noi siamo gli ispiratori, poi i registi, ma anche i profeti. Ed il tutto solo a tempo determinato. In quale misura, attraverso quali proposte, ed anche con quale linguaggio, abbiamo il diritto di ipotecare il loro futuro?
Un’amica medico criticava la mia linea polisportiva precoce evocando gli spettri dei grandi campioni che hanno venduto il proprio corpo per denaro… come non essere d’accordo? In generale, esiste un concreto pericolo di creare, con le migliori intenzioni, dei mostri. Di ciò parlava bene Adriano Sofri (e credo a ragion veduta). Si chiama eterogenesi dei fini, anche di quelli più nobili: partire con alti ideali e fallire nel peggiore dei modi, provocando danni talvolta irreversibili. Problemi di meta-conoscenza… che ne sai oggi di cosa succederà domani attorno a te? Ed allora meglio non far proprio nulla? Dipende dall’alternativa, lo sappiamo benissimo. Ma torno alle mie osservazioni.
Chi li ha spinti Martedì, questi giovanissimi, a presentarsi puntualmente al campo d’atletica con la pioggia, tempo da schifo, per essere oggetto delle mie sperimentazioni controcorrente? Che cosa fa sembrare loro qualcosa di vagamente edificante due ore di scatti dietro ad un vortex su un prato scivoloso? Quale legame, o per lo meno nesso, si delinea (nella fantasia di bambini) tra lo sport strutturato dell’offerta associazionistica ed il mio ideale d’un giovane che cresca innanzitutto da atleta (senza alcuna particolare esigenza d’utilizzare l’agonismo quale prematura chiave di lettura delle sue attitudini)? Dov’è e com’è che il gioco diventa magicamente uno sport ma non lavoro?
Mi dissero, al primo corso universitario, che la differenza tra architettura ed ingegneria era innanzitutto quella d’un biennio non organizzato come uno sbarramento: altrimenti molti creativi talentuosi sarebbero stati buttati a mare a causa di qualche esame scoglio assolutamente settoriale. E mi parve un bel discorso. Vogliamo bruciare dei futuri sportivi a causa di qualche insensata delusione natatoria, ginnica o tennistica? Vogliamo strumentalizzarli ancora in culla proiettando su di loro le nostre piccole ambizioni consumistiche?
Nuovamente, guardo ed ammiro instancabile i loro movimenti, gli appoggi, i piedi scalzi nella piccola ma attrezzata palestra di Feletto. Piedi che altrove s’infangano sulle gradinate fatiscenti d’un campo d’atletica leggera spettrale: in mezzo ad un prato dove solo un discobolo inossidabile, dall’altra parte dell’ovale, da un senso ai fari accesi d’una struttura pubblica che sopravvive a se stessa. O almeno così mi sembra.
Perché solo noi, mi chiedo, a fare ciò che tutti dovrebbero? Tutti i genitori con figli di buona volontà? Tutti gli istruttori di base? Tutti i piccoli pazienti di medici scrupolosi?
Perché se ho ragione io è così terribilmente difficile sentirsi sereni, dalla parte della consapevolezza e della saggezza?
Search
Cerca
Ultime News
SOCIAL
© Vibes Media SRL
Nessun commento