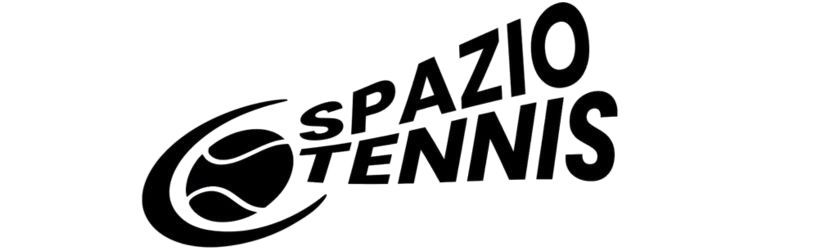(Marco Pedrini, a sinistra, con il “nostro” Fabio Colangelo)
di Gianfilippo Maiga
Marco Pedrini non si può propriamente definire un ex. Se è vero che, a soli 29 anni, è da diversi anni assente dal circuito internazionale, è altrettanto vero che come tennista è attIvo, anzi attivissimo, nei circuiti nostrani e in campionati a squadre di alto livello italiani e non, come testimonia una classifica italiana (2.1), di tutto rispetto.
A soli 29 anni, sei già da tempo fuori dal circuito internazionale. E sì che la tua carriera prometteva bene, con un best ranking di 294 a 22 anni. Quando hai smesso e cosa ti ha indotto a smettere?
Ho abbandonato di fatto nel 2008, a 25 anni. Mi ha fatto decidere in questo senso la mancanza di stimoli che mi derivava dal non essere stato capace non solo di ripetere, ma anzi di migliorare, i risultati del 2005, il mio anno di maggior successo. Non volevo essere solo un “giocatore da challenger” : io, come persona, non mi accontento di vivacchiare. Allora facevo, come tanti del resto, moltissimi sacrifici. Ritenevo che questi avrebbero dovuto essere ripagati non solo e non tanto da guadagni più alti, anche se il problema ovviamente si poneva, ma – almeno per come sono io – dalla gratificazione di una riuscita più piena. Volevo essere lì, tra i primi 100, e sentirmi inserito in un ambiente che giudicavo il più professionale e motivante per il mestiere che mi ero scelto. Non mi bastavano quindi i Challenger, dove ti sembra a volte di galleggiare in un limbo. Avevo e ho molti interessi e curiosità: dedicarmi quindi per un tempo indefinito al 100% al tennis professionistico internazionale si sarebbe giustificato solo se fossi stato capace di fare il grande balzo. A volte nel circuito inferiore trovi comunque grandi difficoltà agonistiche e, se ti gira male per quante qualità tu abbia, rischi di venire risucchiato, come spento, da un’atmosfera di incompletezza, quasi di rassegnazione, di entrare in una spirale negativa dalla quale è difficile risollevarsi.
Qual è la tua storia tennistica? Cosa cambieresti se potessi tornare indietro?
Fino ai 16 anni mi sono allenato a Brescia con Emidio Rossi. Ero considerato uno junior promettente e la Federazione mi ha sostenuto fino ai 18 anni. Giocavo, devo dire, fondamentalmente in Italia e poco a livello internazionale. A 16 anni, dato che desideravo intraprendere la carriera del tennista, mi sono trasferito a Roma con Coppo. Coppo è stato per me una guida molto importante e, insieme a Pietro Angelini, una specie di fratello maggiore per me, essenziale nella mia formazione. I suoi metodi, va detto, erano particolari, dato che poneva tantissimo per esempio l’accento sull’aspetto mentale, sulle sensazioni, (ricordo che a volte faceva giocare scalzi) ed era anche un po’ filosofo. Purtroppo quando avevo 19 anni, (un momento che ritengo cruciale nello sviluppo di un tennista giovane, cui andrebbero dedicate tutte le attenzioni), la situazione a Roma era cambiata. Il gruppo si era allargato e non in modo omogeneo. Coppo seguiva anche professionisti affermati (Galvani fra tutti) e donne in carriera tennistica. Pur non essendo trascurato, capivo che il mio allenatore doveva suddividersi e non poteva dedicarmi il tempo di cui sentivo di aver bisogno. Sono allora tornato più vicino a casa, appoggiandomi a Nicola Bruno, ex-giocatore, 2 anni a Cremona, 1 anno a Trento (Bruno lavorava come maestro all’ATA Battisti, e la mattina mi poteva seguire a tempo pieno, mentre il pomeriggio mi inseriva in un gruppo agonistico) e infine alcuni mesi a Barcellona. Siamo nel 2004. In cerca di una situazione più a misura delle mie esigenze sono tornato in Italia, lavorando a Milano nella struttura gestita da Bonaiti, che annoverava allora diversi giocatori, (Ocera, Stoppini, Livraghi, Galli, Menga tra gli altri). Qui ho avuto i miei risultati migliori, culminati nel 2005 nel raggiungimento del mio best ranking, ma, successivamente, qui ho cominciato a nutrire anche i primi dubbi. In tutti questi anni avevo girato per tornei senza accompagnamento; solo occasionalmente quando il gruppo cui ho accennato si muoveva insieme si aveva a volte l’opportunità di essere accompagnati. È importante parlare della solitudine del tennista. La solitudine di un ragazzo che non ha uno staff dedicato, o anche solo un accompagnatore che si occupi di lui, è a volte un grande disturbo per il tennis, specie se parliamo di un ventenne o poco più. Ci sono da risolvere i problemi logistici e da scoprire la situazione di gioco che troverai, (campi per allenarsi, non sempre per scontati, sparring, stanza di hotel da dividere se no ti costa un botto, compagno di doppio, orari di partenza e prenotazioni aeree) e poterli dividere o addirittura non pensarci è davvero un grande aiuto, ma è un privilegio per pochi. Non parliamo poi dell’attesa dei match, della conoscenza e della valutazione obiettiva dell’avversario. Girare da solo, essere soli psicologicamente e fisicamente significa molte cose e, tra queste, che si ha molto tempo per pensare, (i tempi morti sono numerosi e spesso inevitabili: ricordo una volta in Croazia quando piovve per molti giorni di fila). Se hai qualcuno con cui dividere i tuoi pensieri ti aiuta a gestire i momenti difficili e ad avere una visione molto più serena ed equilibrata delle cose. Vedere che altri tennisti avevano a disposizione mezzi e assistenza di cui non disponevo, pensare che forse anche per quella ragione non riuscivo a decollare, mi ha fatto nascere molti interrogativi e instillare dubbi cui solo io finivo con il dare una risposta. Quando, come accade spesso, nel 2007 il gruppo Bonaiti si è sfaldato, avevo già avuto modo di riflettere lungamente sul mondo in cui stavo e su come lo stavo affrontando. Mi sono dato allora ancora un anno, questa volta a Brescia, con Tavelli, (che aveva seguito Francesca Schiavone), un iperprofessionista, ma nel 2008 ho detto basta. Paradossalmente, non cambierei molto di quello che ho fatto, ma un rimpianto ce l’ho: non aver preso la strada del college americano, dove mi sarei comunque allenato e avrei giocato a tennis ad alto livello, ma con una laurea pagata e un’esperienza irripetibile.
 Cosa fai oggi e come vedi il tuo futuro? Manterrai un rapporto con il tennis?
Cosa fai oggi e come vedi il tuo futuro? Manterrai un rapporto con il tennis?
Gioco tantissimo, ma nel mio futuro non c`è solo tennis. Certo, non butto via gli anni che ho investito in questo mestiere, che peraltro mi diverte moltissimo, ma voglio fare anche altro. A dicembre mi laureo in Scienze Politiche alla Statale di Milano e, dopo un Master che sto pensando di frequentare, spero in un futuro nel management o nel marketing sportivo. In questi anni, comunque, oltre a studiare per prendere una laurea, ho giocato molto: gli open italiani, (prima della crisi ce n’era uno a settimana), i campionati di serie A in Italia, (Sarnico), Germania e Francia, un’attività, va ben detto, molto più remunerativa dei Future e dei Challengers. I campionati a squadre sono bellissimi: mi piace l’atmosfera di squadra, il cameratismo e l’idea di competere insieme, quello che ti manca decisamente quando giochi per te stesso. Non mi vedo invece coach o, men che meno, maestro. In questi anni ho fatto un po’ di tutti e due, (ho dato qualche lezione d’inverno e ho accompagnato per un po’ Maria Elena Camerin) e non credo che mi interessi proseguire nell’esperienza. Non che non ci sarebbe spazio, da quanto visto in giro, specie a livello femminile…
Come valuti il tennis di oggi, con particolare riferimento alla situazione italiana?
Il tennis odierno corre verso una sempre maggiore professionalizzazione, soprattutto in campo maschile. La novità è che questo approccio non è più richiesto solo agli atleti adulti, ma anche a livello giovanile, almeno per quanto riguarda i giovani di élite. Gli juniors più forti al mondo sono ormai dei professionisti, che curano l’aspetto tecnico quanto quello mentale e quello fisico, altrettanto importanti tra loro. Per un giovane, dunque, emergere è sempre più difficile, anche perché non sempre le pressioni, i sacrifici e la dedizione che si chiedono sono sostenibili a 15-16 anni. Sono troppo fuori dal contesto per poter esprimere una valutazione seria sul movimento italiano e sulla Federazione. Da quanto leggo noto con piacere che diversi giovani si stanno affacciando al mondo professionistico con ottime prospettive. Se posso fare un’osservazione, ricordando esperienze passate, la raccomandazione che mi sento di fare è che la federazione sostenga una base ampia di giovani anche fino al momento dell’ingresso al professionismo e non si limiti, alla fine, a supportare pochissimi eletti. La maturazione di un tennista può avvenire dopo i 18 anni e, anzi, spesso un bravissimo junior capita non mantenga le premesse, mentre altri, talentuosi ma incostanti a livello di risultati da juniores, trovano solo in seguito la “quadra” delle proprie capacità e proprio per questo vanno aiutati negli anni più delicati, altrimenti si perdono. Devo anche dire che intorno a me, nel mondo degli allenatori italiani, vedo troppa improvvisazione e non molta competenza e questo aggiunge un ostacolo alle già grandi difficoltà che un giovane incontra. Spesso vedo giovani accompagnatori pieni di buona volontà, ma non dotati delle necessarie conoscenze e mi domando come possano aiutare un giovane alle prime armi. Raramente poi mi capita, per esempio, di vedere un allenatore che va in profondità ad analizzare i punti forti di un tennista che segue e a lavorare per valorizzarli e “limare” i punti deboli; più spesso si opera in modo standardizzato e in base alle categorie che si conoscono. Parlo al maschile, ma purtroppo e soprattutto anche con riferimento al mondo femminile. Ho sempre fatto e faccio molta fatica a seguire il tennis al femminile, anche perché confesso che gli incontri maschili mi appassionano di più.
Cosa ricordi della tua esperienza da professionista in giro per il mondo? Ricordi personaggi e “avventure” della tua carriera?
Soprattutto chi ha calcato in genere palcoscenici meno prestigiosi di quelli che la televisione ci mostra ha molti aneddoti da raccontare. Non è solo la “fauna” che popola quel mondo, ( a cominciare dalla pittoresca pletora di “parenti allenatori e accompagnatori” che si incontrano soprattutto nei tornei femminili, spesso ridicolmente veri e propri schiavi dei capricci muliebri) a fornire degli spunti. Un aspetto davvero problematico è, per esempio, la logistica: i tornei raramente sono nelle grandi piazze, e spesso i collegamenti costituiscono un vero e proprio rompicapo, che deve sbrogliare interamente il malcapitato tennista, checchè si dica. Vorrei rievocare una mia disgraziata spedizione in Uzbekistan nel 2005, una striscia di 2 Challenger. Nel primo mi sono beccato un’influenza e, oltre allo scorno di dovermi ritirare dopo il primo turno, ricordo la necessità di schivare l’assedio di (molto) dubbi medici locali, che volevano rifilarmi intrugli di ogni tipo. Nel secondo avevo invece perso di giovedì pomeriggio nei quarti, scoprendo purtroppo che i collegamenti aerei per il ritorno erano solo di giovedì e lunedì . Conseguenza: uno stupendo quanto costoso fuori programma “turistico” a Tahkent, in attesa del lunedi successivo, (in realtà ero nel mio anno d’oro e avevo trascorso il week end a allenarmi intensamente). Ho incrociato anche più di un tennista tra quelli che oggi popolano gli schermi televisivi. Ne ricordo 2, tra gli altri: Murray e Del Potro, da me incontrati e battuti in altrettanti Future. Murray aveva 17 anni e aveva un atteggiamento spocchioso e arrogante, modi sufficienti e altezzosi. Del Potro, con cui avevo vinto al terzo in una semifinale, era di tutt’altra pasta. Mi avevano colpito la sua serietà, il suo approccio alla partita, oltre che naturalmente le sue qualità tennistiche. Ricordo bene che alla fine del match gli dissi che per quella volta avevo vinto io, ma che ero certo che presto lo avrei visto, dal mio divano, su SKY.
Hai vissuto l’atmosfera dei circuiti internazionali e poi quella degli open. Puoi fare un confronto?
Sono mondi diversi e non solo per l’aspetto più strettamente tennistico. A titolo personale devo ammettere che almeno inizialmente ho dovuto superare la difficoltà psicologica legata al cambiamento di palcoscenico. Il passaggio da campi e piazze comunque di una certa importanza e con un certo seguito, in presenza di condizioni organizzative predefinite e abbastanza omogenee a teatri affatto diversi , (magari su un campo seminascosto in un circolo deserto senza cambio palle,arbitro e pubblico, soprattutto nei primi turni), mentalmente non è di cosi immediata assimilazione. Quanto al livello di gioco, i Future e i Challenger sono certamente tornei di professionisti, gente che ha deciso di dedicarsi al mestiere del tennista e che, a prescindere dai suoi guadagni e dal suo ranking, è per lo più altamente preparata per quell’impegno: lo sforzo in questi tornei è quindi di grande livello, specie oggi. Non si pensi però che gli Open siano una passeggiata di salute. Innanzitutto allenamento e stimoli non possono mancare altrimenti.. in fondo non ci si arriva. Quanto agli avversari, puoi scontrarti con ex giocatori atp come me, oppure con giovani che si allenano ore tutti i giorni, ben più di me ormai, oppure ancora contro il giocatore con un’importante classifica mondiale che quella settimana ha deciso, per vari motivi, di giocare l’open. Per non parlare degli argentini e brasiliani che, durante il periodo primaverile delle competizione a squadre in Italia, popolano il circuito open supermotivati. Categorie diverse, ma con in comune la caratteristica di essere tutte estremamente ardue da affrontare. C’è infine un aspetto fortemente positivo che mi sento di riconoscere al mondo open. Nei tornei atp l’unica cosa che importa al giocatore sono il gioco, i punti e le vittorie, e aggiungerei giustamente. Nel circuito open ho invece potuto notare in questi anni la costante di un più forte rapporto umano tra giocatori e staff organizzativo del torneo. Qui si dà più spazio ai rapporti personali e si socializza di più, e questo penso sia un aspetto non marginale nel praticare il nostro sport.