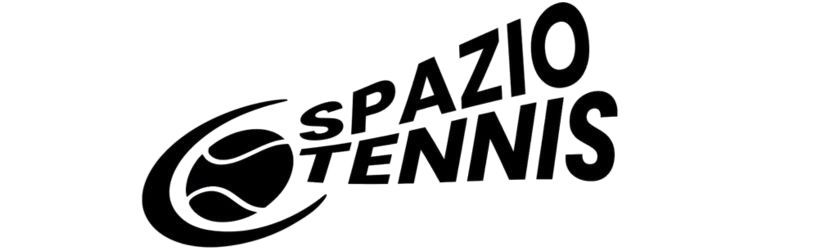di Luca Brancher
Per quanto Roger Federer gli abbia, anno dopo anno, levato buona parte dei record che, faticosamente, si era conquistato, Pete Sampras, con ogni probabilità, potrà fregiarsi di un traguardo che, non solo è difficilmente raggiungibile, ma potrebbe diventare una sorta d’ossessione per tutti quei campioni che, ponderata l’opportunità di un ritiro, sognino di farlo nella stessa maniera del “King of Swing”: vincendo un titolo Slam, magari quello di casa. Pete ce l’ha fatta nel 2002, e non è un segreto che l’eterno rivale Agassi, quattro anni più tardi, avrebbe sognato di emularlo, prima di infrangersi al cospetto di Benjamin Becker. Non è eresia pensare che l’elvetico più famoso dello sport possa ambire ad effettuare la stessa uscita di scena ed è altresì certo che è una tematica molto discussa la modalità con cui uno sportivo è meglio abbandoni i palcoscenici: all’apice, oppure quanto mestamente si è già imboccata la parabola discendente? Comunque sia, un’ultima passarella, davanti al pubblico di casa, la sognerebbero tutti. Non era da meno Wayne, quando, compreso che non vi sono tanti domani agonistici quando gli anni sono ormai 36, decise che l’Australian Open del 2007 sarebbe stato l’ultimo. E non faceva riferimento allo Slam australe senza un motivo preciso, dal momento che è la manifestazione tennistica più importante tra quelle che si svolgono sul suolo natio.
Wayne è Arthurs, tennista australiano che oggi raggiunge le 44 primavere e che ha sempre rincorso i suoi sogni in evidente affanno, visto che ogni tappa della sua carriera è stata raggiunta con quel briciolo di ritardo che ci porta, idealmente, ad avvicinare il suo profilo a quello del nostro Davide Sanguinetti, di cui è soltanto un anno più vecchio: entrambi hanno raggiunto l’apice in un’età in cui molti altri avevano già abbandonato. Curiosità anagrafica a parte, i due hanno estrazione e gioco piuttosto differenti, per cui ci libereremo qui di questo parallelismo e ci soffermeremo sul ragazzo di  Adelaide, figlio di un ex-professionista, rappresentante Davis dell’Irlanda, poi emigrato in Oceania, Derek. Una caratteristica che denota correttamente Arthurs, come già anticipato, si riferisce alla sua comparsa nel radar degli appassionati medi in età già piuttosto avanzata. Era l’estate del 1999, Wayne aveva da poco compiuto 28 anni e solo da qualche tempo era riuscito ad imporsi in uno sport il cui ranking mondiale, per diverse stagioni, nel corso degli anni ’90, lo aveva relegato ai margini. D’altronde, con quel servizio mancino così infido e l’abilità a rete che gli conferiva lo status di tennista australiano d.o.c., compensate da varie carenze a fondo campo, Arthurs aveva pensato di poter rendere al meglio soprattutto nella disciplina del doppio, verso cui in effetti concentrò i suoi principali sforzi. Si sbagliava, almeno in parte, perché, una volta acquisita esperienza, comprese che poteva raccogliere qualcosa di più di quanto preventivato anche in singolare, soprattutto su quella superficie che aveva reso celebri tanti connazionali: l’erba. Fu proprio la sua prima volta nel tempio londinese di Wimbledon a regalargli la ribalta: dopo aver superato agevolmente le qualificazioni, l’australiano cominciò a regolare avversari su avversari anche nel main draw. Il primo fu il nostro Vincenzo Santopadre, poi toccò all’ecuadoriano Nico Lapentti ed infine al tedesco Tommy Haas, qualificandosi così alla seconda settimana dopo aver ceduto soltanto un set – proprio all’azzurro – in sei partite, e con un record nei tie break che recitava un eloquente 11-1. Wayne era pronto ad una sfida molto suggestiva, che lo avrebbe opposto allo statunitense Andre Agassi, quarta testa di serie, che il lunedì successivo si sarebbe seduto sulla prima poltrona della classifica mondiale.
Adelaide, figlio di un ex-professionista, rappresentante Davis dell’Irlanda, poi emigrato in Oceania, Derek. Una caratteristica che denota correttamente Arthurs, come già anticipato, si riferisce alla sua comparsa nel radar degli appassionati medi in età già piuttosto avanzata. Era l’estate del 1999, Wayne aveva da poco compiuto 28 anni e solo da qualche tempo era riuscito ad imporsi in uno sport il cui ranking mondiale, per diverse stagioni, nel corso degli anni ’90, lo aveva relegato ai margini. D’altronde, con quel servizio mancino così infido e l’abilità a rete che gli conferiva lo status di tennista australiano d.o.c., compensate da varie carenze a fondo campo, Arthurs aveva pensato di poter rendere al meglio soprattutto nella disciplina del doppio, verso cui in effetti concentrò i suoi principali sforzi. Si sbagliava, almeno in parte, perché, una volta acquisita esperienza, comprese che poteva raccogliere qualcosa di più di quanto preventivato anche in singolare, soprattutto su quella superficie che aveva reso celebri tanti connazionali: l’erba. Fu proprio la sua prima volta nel tempio londinese di Wimbledon a regalargli la ribalta: dopo aver superato agevolmente le qualificazioni, l’australiano cominciò a regolare avversari su avversari anche nel main draw. Il primo fu il nostro Vincenzo Santopadre, poi toccò all’ecuadoriano Nico Lapentti ed infine al tedesco Tommy Haas, qualificandosi così alla seconda settimana dopo aver ceduto soltanto un set – proprio all’azzurro – in sei partite, e con un record nei tie break che recitava un eloquente 11-1. Wayne era pronto ad una sfida molto suggestiva, che lo avrebbe opposto allo statunitense Andre Agassi, quarta testa di serie, che il lunedì successivo si sarebbe seduto sulla prima poltrona della classifica mondiale.
La magia che solo certi palcoscenici, come i campi principali dell’All England Lawn Tennis Club, sanno sprigionare ben si addiceva all’occasione. Il ragazzo di Adelaide, forse troppo adulto per lasciarsi andare all’emozione, ebbe in effetti un impatto tutt’altro che timoroso con la grande platea britannica e sin dai primi giochi non esitò a mettere in mostra quel tennis che tanto aveva impressionato. Pur trovandosi di fronte uno dei più grandi ribattitori che la storia del tennis moderno ricordi, Arthurs manteneva inalterato il suo ruolino intonso al servizio – mai era infatti stato breakkato – condizione sufficiente a spingerlo al tie break della prima frazione, dove, e qui fu davvero somma sorpresa per tutti, centrò un clamoroso successo per 7-5. La gioia di Wayne fu ben bilanciata dallo stupore, da quello dei semplici spettatori fino a quello dei maggiori esperti, tra cui non poteva mancare il decano dei giornalisti, Gianni Clerici – impegnato a commentare assieme a Rino Tommasi quello stesso match – che incredulo si lasciò scappare un “Vuoi vedere che abbiamo trovato il giocatore capace di vincere Wimbledon da qualificato?”. L’incantesimo si sarebbe presto rotto: tempo di perdere, sempre al tie break, il secondo set, che l’australiano cominciò ad accusare la stanchezza, patita in maniera particolare perché privato di quell’aurea di imbattibilità, e nelle restanti due frazioni concesse ben tre volte la battuta all’esperto kid di Las Vegas, fresco campione del Roland Garros. L’eliminazione non poteva cancellare quanto di buono fatto in quelle due settimane, tra Roehampton e Wimbledon.
Ben diversa fu invece l’esperienza che lo stesso Arthurs visse a Londra tre anni dopo, quando il suo nome era ormai noto e soprattutto il suo iter professionistico aveva oltrepassato diversi scaglioni di miglioramento, tra cui l’ aver eliminato, nel corso dello U.S. Open del 2000, il secondo giocatore al mondo, Gustavo Kuerten – lui era numero 102, e quello fu un avvenimento che permise di rafforzare la tesi secondo cui ormai era possibile per il numero 100 battere il primo della classe, fino a poco prima impensabile. Quell’edizione del 2002 non fu esattamente la più incline ad assecondare le credenziali dei favoriti – ricorderete Sampras sconfitto da Bastl – per cui i buchi nel tabellone divenivano sempre più simili a voragini, giorno dopo giorno. Soprattutto la parte bassa, quella non capitanata dal futuro vincitore Lleyton Hewitt, assomigliava ad una gara ad eliminazione diretta in cui gli sfidanti si auto-boicottavano. Wayne coltivava l’idea di estrarre dal cassetto quel sogno innominabile, e giunto agli ottavi di finale in una zona in cui gli avversari per un posto in finale erano o troppo vecchi per essere competitivi o troppo giovani per non avvertire il fascino della situazione, subì un vero contraccolpo psicologico quando fu eliminato in quattro set da David Nalbandian, poi finalista. La chance sprecata, con annessi set point per allungare la partita al quinto, segnò il più grande rimpianto della sua carriera, tanto che quella sera, per lui, fu davvero difficile lasciare lo spogliatoio di Wimbledon, visto che il momento, tanto atteso, gli era sfuggito.
 Tra alti e bassi, tra cui il primo insperato titolo in singolare ottenuto nel febbraio del 2005 a Scottsdale, si giunse all’epilogo cui si faceva cenno nell’ incipit. Pur non vantando atleti in quantità copiosa, Wayne Arthurs non era mai stato un vero e proprio beniamino del pubblico locale, ma l’annuncio del ritiro, unitamente al fatto che nel tabellone principale di quell’Australian Open risultava il giocatore più anziano, spinse gli australiani, per una volta, a stargli vicino. E a beneficiarne fu lo stesso giocatore, che si aggiudicò due incontri in rimonta, di due set al primo turno contro Stefan Koubek e di un set al secondo contro Zack Fleishman. Per il terzo match, contro Mardy Fish, Wayne ottenne di esordire alla Margaret Court Arena, per un tributo a cui avrebbero dovuto partecipare migliaia di persone. Purtroppo, se le prime due partite lasciavano intendere che tutte le tessere del puzzle denominato “L’addio da sogno di Wayne Arthurs” stavano incastrandosi alla perfezione, l’amara sorpresa lo stava attendendo dietro l’angolo. Durante il riscaldamento mattutino, Wayne avvertì un dolore all’anca che lo portò a ricorrere ad una puntura di anestetico per arrivare in forma smagliante al match del pomeriggio. Sfortuna volle che quell’infiltrazione gli provocò una reazione che, a detta del medico che gliela operò, ha un rischio che si scateni pari allo 0,1%: a causa di questo, Arthurs scese in campo con un ginocchio fuori uso e soprattutto con la percezione di non riuscire a coordinarsi correttamente. Tutto questo lo spinse, dopo soli tre giochi e due break subiti, ad alzare bandiera bianca, e l’addio davanti al suo pubblico si trasformò in una rapida fuga verso l’ospedale.
Tra alti e bassi, tra cui il primo insperato titolo in singolare ottenuto nel febbraio del 2005 a Scottsdale, si giunse all’epilogo cui si faceva cenno nell’ incipit. Pur non vantando atleti in quantità copiosa, Wayne Arthurs non era mai stato un vero e proprio beniamino del pubblico locale, ma l’annuncio del ritiro, unitamente al fatto che nel tabellone principale di quell’Australian Open risultava il giocatore più anziano, spinse gli australiani, per una volta, a stargli vicino. E a beneficiarne fu lo stesso giocatore, che si aggiudicò due incontri in rimonta, di due set al primo turno contro Stefan Koubek e di un set al secondo contro Zack Fleishman. Per il terzo match, contro Mardy Fish, Wayne ottenne di esordire alla Margaret Court Arena, per un tributo a cui avrebbero dovuto partecipare migliaia di persone. Purtroppo, se le prime due partite lasciavano intendere che tutte le tessere del puzzle denominato “L’addio da sogno di Wayne Arthurs” stavano incastrandosi alla perfezione, l’amara sorpresa lo stava attendendo dietro l’angolo. Durante il riscaldamento mattutino, Wayne avvertì un dolore all’anca che lo portò a ricorrere ad una puntura di anestetico per arrivare in forma smagliante al match del pomeriggio. Sfortuna volle che quell’infiltrazione gli provocò una reazione che, a detta del medico che gliela operò, ha un rischio che si scateni pari allo 0,1%: a causa di questo, Arthurs scese in campo con un ginocchio fuori uso e soprattutto con la percezione di non riuscire a coordinarsi correttamente. Tutto questo lo spinse, dopo soli tre giochi e due break subiti, ad alzare bandiera bianca, e l’addio davanti al suo pubblico si trasformò in una rapida fuga verso l’ospedale.
Oltre al danno, la beffa. Nel raccontare questo avvenimento, il commentatore della tv australiana, Ian Fowler, si permise di schernire il suo connazionale, definendo l’uscita di scena di Wayne di tutt’altro tenore rispetto a quella che pochi mesi prima era stata inscenata da Andre Agassi allo U.S. Open, non cogliendo assolutamente il grave stato di malessere che stava colpendo il povero atleta. Giusto che Arthurs traesse forza, da quell’esperienza, per proseguire fino alla successiva edizione di Wimbledon, la vera vetrina del suo tennis, dove trovò nuovamente il modo di issarsi fino al terzo turno (superando Tommy Robredo, top-ten), pur venendo seccamente sconfitto da Jonas Bjorkman: almeno qui, però, uscì dal campo sulle sue gambe e non ci fu nessuno che ebbe l’ardire di rinfacciargli la scadente prestazione. Ad otto anni di distanza, l’Australia vive un periodo di ritrovata serenità, con nuove leve volenterose di rimettere la loro nazione al centro della cartina mondiale del tennis, creando uno iato che va al di là del lasso temporale rispetto a quando a giocare c’era il nostro Arthurs, capace col tempo di raggiungere la seconda settimana in tre Slam su quattro – tranne proprio a Melbourne – le semifinali in tre Slam di doppio – dove è arrivato ad un passo dalla top ten ed ha pure partecipato ad un Master di fine anno – e la top-50 in singolare (best ranking al numero 44, colto a 30 anni). Certo l’epilogo a casa è stato il peggiore possibile, ma è quello che c’è stato prima che è valso la pena vivere.